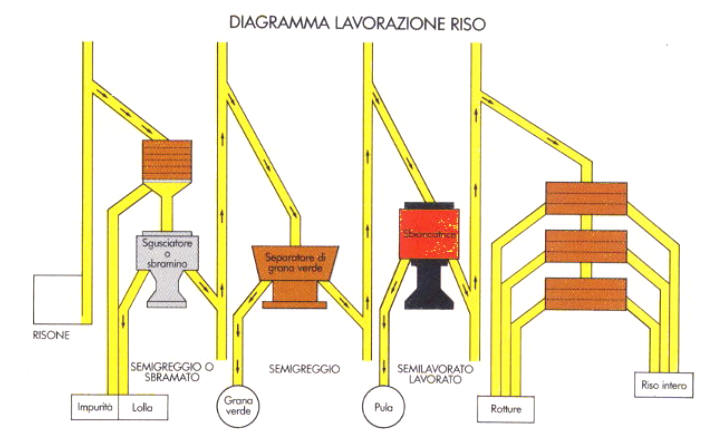Dall’Ottocento ai
giorni nostri, l’industria della lavorazione del riso ha subito radicali
trasformazioni, che riguardano soprattutto aspetti tecnici e logistici.
Come già detto, inizialmente la lavorazione del riso era svolta a livello
strettamente locale: in quasi tutti i paesi esisteva almeno un molino
che serviva, oltre che alla macinazione della meliga, anche alla
brillatura del riso, ossia quell’operazione che consiste nell’eliminare
l’involucro naturale dal chicco.
I molini erano costituiti da grandi ruote a pale di legno poste su un corso
d’acqua in un punto in cui vi fosse un "salto", cioè un dislivello
sufficiente per far girare la ruota. Mediante un sistema d’ingranaggi il
moto delle pale faceva ruotare una macina superiore che girava sopra una
inferiore fissa.
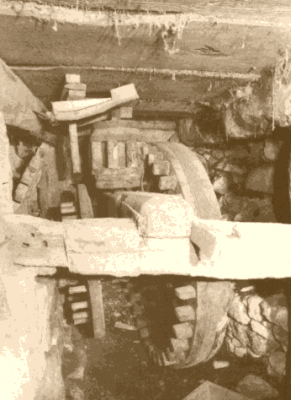
Ruota a pale di un mulino

Palestro - Mulino vecchio
Una figura tipica
dell’epoca era quella del pilatore (chiamato anche "Pilù" o
"Pilota"). I pilatori erano i Maestri delle "pile", chiamate
anche "piste", fabbriche nelle quali fino alla metà dell'Ottocento il riso
veniva lavorato (in francese: pilè, ossia scortecciato, pulito) mediante una
o più batterie di cilindri entro i quali un pestello (in francese: pilon)
ritmicamente s'alzava e si abbassava prima scortecciandolo, poi sgrezzandolo.
In pratica il riso doveva essere posto in una serie di mortai e colpito
da pestelli di legno che però non dovevano arrivare fin sul fondo per non
schiacciare i chicchi: era solo la percussione e lo sfregarsi del riso
contro le pareti del mortaio che lo liberava dalla buccia.
Le pile sorgevano tra le risaie, in riva ai canali o sugli argini. Qui, il
Maestro ed i suoi aiutanti trascorrevano la campagna della pilatura, da metà
settembre al giorno di Sant'Antonio Abate, a metà gennaio.
Ancor oggi i capi fabbrica nelle raffinerie di riso sono chiamati "Capi
Pila", e "Pilatori" son detti gli specialisti della linea di lavorazione a
bianco.
Le varie fasi di
lavorazione del riso, che prima erano eseguite nei singoli poderi, dalla
fine dell’’800 iniziarono ad essere realizzate in stabilimenti di più grandi
dimensioni e maggiormente attrezzati: le riserie.
Le industrie cominciarono ad acquisire una fisionomia tecnica verso il 1870
– 1875, conseguendo con il perfezionamento dei macchinari i vantaggi di una
maggiore resa e di una migliore presentazione del prodotto.
I grandi impianti sorsero dapprima vicino ai porti per poter lavorare sia il
risone italiano che quello estero (ad esempio la ditta Frugone e Preve
impiantò il primo stabilimento a Genova), successivamente si diffusero nelle
zone di coltura del riso e nel Vercellese in particolare.
Dalla consultazione di documenti risalenti al 1889, si rileva che all’epoca,
nel territorio di Vercelli, esistevano almeno sei grandi riserie, di
carattere industriale o agricolo-industriale, che, utilizzando una forza
motrice di 205 cavalli dinamici, potevano produrre oltre 115.000 quintali di
riso lavorato l’anno. Il prodotto finito era destinato specialmente al
mercato estero.
Fino alla seconda guerra mondiale esistevano comunque due categorie distinte di esercizi di lavorazione del riso:
- Le pilerie industriali, meglio note come riserie
- Le pilerie agricole che svolgevano lavorazioni dirette al consumo familiare utilizzando per lo più energia idraulica.
Nell’albo degli impianti
del 1935 tenuto dall’Ente Nazionale Risi, nelle province di Vercelli ed
Alessandria, si contano 138 pilerie industriali e 49 pilerie agricole.
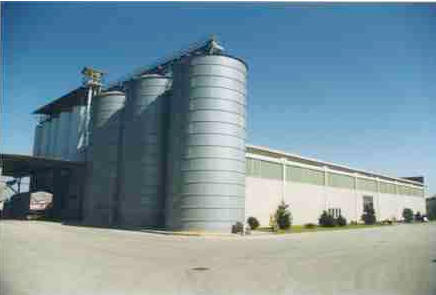
Attualmente, per ciò che riguarda le numerose aziende che operano nel settore risicolo, si può effettuare la seguente distinzione:
![]() pilerie
agricole:
mantengono sostanzialmente le caratteristiche di un tempo; esse svolgono
un’attività saltuaria e stagionale, che utilizza mezzi prettamente manuali.
Il prodotto agricolo viene lavorato sul posto e venduto sfuso (sotto forma
di “riso integrale” o “naturale”) ad un numero limitato di acquirenti al
minuto. Negli ultimi anni queste lavorazioni sono state rivalutate per
un’attenzione accresciuta verso tutto ciò che è biologico e genuino.
pilerie
agricole:
mantengono sostanzialmente le caratteristiche di un tempo; esse svolgono
un’attività saltuaria e stagionale, che utilizza mezzi prettamente manuali.
Il prodotto agricolo viene lavorato sul posto e venduto sfuso (sotto forma
di “riso integrale” o “naturale”) ad un numero limitato di acquirenti al
minuto. Negli ultimi anni queste lavorazioni sono state rivalutate per
un’attenzione accresciuta verso tutto ciò che è biologico e genuino.
![]() piccole
riserie: si
tratta di aziende quasi sempre a conduzione familiare e che comprendono
poche unità produttive. Sono dotate di una scarsa produttività; per questo,
si rivolgono ad un limitato numero di negozi al dettaglio oppure effettuano
lavorazioni conto terzi, senza operare direttamente nel mercato di sbocco.
piccole
riserie: si
tratta di aziende quasi sempre a conduzione familiare e che comprendono
poche unità produttive. Sono dotate di una scarsa produttività; per questo,
si rivolgono ad un limitato numero di negozi al dettaglio oppure effettuano
lavorazioni conto terzi, senza operare direttamente nel mercato di sbocco.
![]() aziende di
piccole dimensioni:
sono tecnologicamente piuttosto avanzate; ciò le rende operative anche sul
mercato estero. Sono stanziate sul territorio nazionale nelle aree in cui la
concorrenza è meno agguerrita, mentre per la copertura all’intero territorio
si avvalgono della distribuzione capillare di aziende alimentari, a cui
trasferiscono parte della produzione.
aziende di
piccole dimensioni:
sono tecnologicamente piuttosto avanzate; ciò le rende operative anche sul
mercato estero. Sono stanziate sul territorio nazionale nelle aree in cui la
concorrenza è meno agguerrita, mentre per la copertura all’intero territorio
si avvalgono della distribuzione capillare di aziende alimentari, a cui
trasferiscono parte della produzione.
Possono attuare due tipi
di lavorazione:
- lavorazione
normale o tradizionale
-
parboilizzazione, procedure idrotermica che garantisce la tenuta in cottura
del prodotto
![]() imprese di
grandi dimensioni:
dispongono di impianti tecnologicamente simili a quelli delle medie imprese,
ma, grazie ad un sistema organizzativo molto efficace, sono in grado di
raggiungere vari segmenti di mercato. Il raggiungimento di buoni margini di
guadagno è dovuto all’ampia varietà di prodotti che offrono e ai notevoli
investimenti pubblicitari.
imprese di
grandi dimensioni:
dispongono di impianti tecnologicamente simili a quelli delle medie imprese,
ma, grazie ad un sistema organizzativo molto efficace, sono in grado di
raggiungere vari segmenti di mercato. Il raggiungimento di buoni margini di
guadagno è dovuto all’ampia varietà di prodotti che offrono e ai notevoli
investimenti pubblicitari.
Tali aziende sono spesso legate attraverso rapporti di partecipazione con
altre imprese di distribuzione, di confezionamento o di commercializzazione.