La villa rustica romana ed
altomedioevale

La villa qui riprodotta è stata costruita in Gallia
in tempi diversi tra il I e il IV secolo d. C. A sinistra un portico a emiciclo
precede l'entrata e ospita un piccolo santuario, al centro un grande cortile (
m. 26 x 22 ) con colonnato su cui si aprono gli appartamenti, in alto le terme
ed il ninfeo. Questa è solo la dimora signorile. Tutto l'insieme della villa si
estendeva su 4 ettari con circa 200 locali di abitazione. Le proprietà che
facevano capo a questa villa erano di circa 1500 ettari, in cui lavoravano non
meno di 500 persone.
Illustrazione tratta da M. Vegetti, Storia delle società antiche, Vol 2,
Zanichelli, 1981
La villa dei ricchi latifondisti
romani testimonia nella stessa grandiosità la crisi delle città nel tardo
impero. Essa raggruppa intorno
all’abitazione del proprietario le lavorazioni artigianali e gli spazi per la
conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli.
Presenta una parte residenziale (abitazione del
proprietario) e una parte produttiva (alloggio della manodopera, impianti
di produzione e magazzini). Il proprietario vi risiedeva abbastanza
stabilmente, mentre la conduzione era affidata a un fattore che faceva
lavorare degli schiavi. Nella villa rustica vi erano
due
corti (cortes): una interna e un’altra esterna.

| A- corte |
| B- cucina |
| C- forno |
| D- apodyterium |
| E- tepidarium |
| F- caldarium |
| G- gabinetto |
| H- stalla |
| J- stanza di deposito per strumenti rustici |
|
K-L- cubicula |
|
M- passaggio |
|
N- stanza da pranzo |
|
O- stanza per il pane |
|
P- stanza del torchio del vino |
|
Q- corridoi |
|
R- cella vinaria |
|
S- fienile |
| T- aia |
| V- cubicula |
| W- stanza per un torchio |
| X- stanza con molino a mano |
| Y- frantoio |
| Z- stanza per la pressa |
In ognuna c’era una vasca (piscina):
quella della corte interna serviva per dissetare gli animali; l’altra, per
alcune operazioni agricole (lasciare a mollo cuoio, lupini, ecc.). Attorno alla prima delle due
corti sorgevano le costruzioni in muratura che erano la parte caratteristica
della villa rustica : la parte della fattoria dove abitavano i servi. Il centro della villa era
rappresentato dalla cucina (culina), che non era il luogo adibito
alla preparazione dei pasti, ma rappresentava uno spazio di riunioni e di
lavoro.
Vicino alla cucina c’erano le
stanze da bagno per i servi, la cantina, le stalle per i buoi (bulina),
per i cavalli (equilia) e, se vi era posto, anche il pollaio.
Lontani dalla cucina c’erano i
granai (granaria), i seccatoi (correa) e le stanze
in cui era conservata la frutta (oporithecae).
I magazzini più esposti al
rischio d’incendio potevano costituire un edificio (villa fructuaria)
completamente separato dall’intero complesso.
A ridosso della villa rustica
c’era l’aia, vicino a cui sorgevano alcuni capannoni, come la rimessa dei carri
agricoli(plaustra) o il nubiliarum, un luogo in cui
riporre provvisoriamente il grano in caso di forti piogge.
Non si conoscono le abitazioni
dei servi, però è certo che esistevano delle stanze da letto (celle
familiares), l’ergastulum, una specie di prigione in cui
gli schiavi aspettavano i lavori duri e il valetudinarium per gli
schiavi ammalati.
In assenza della villa urbana,
le stanze migliori erano riservate al padrone.
Le domus cultae ( moderne aziende agricole ) nascono nel
VIII secolo e rappresentano la struttura del nascente Stato della Chiesa: la
situazione creatasi nel Mediterraneo rendeva difficoltosi gli scambi commerciali
e le importazioni di materie prime, perciò i pontefici furono costretti
ad incentivare l’agricoltura nei territori dei loro domini.
Il primo impulso in questa direzione era stato dato da Gregorio Magno, ma a partire dalla metà dell’VIII, con papa Adriano I, si diffusero in tutta la campagna romana. Attraverso una ricca documentazione, siamo informati sulla struttura e sul funzionamento di una domus culta, quella di Capracorum, posta sul sito di un’antica villa romana presso Veio, nel Lazio settentrionale che era stata lasciata in eredità alla Chiesa, a cui si aggiunsero altri terreni, che comprendevano fattorie, edifici, vigneti, olivi e mulini.
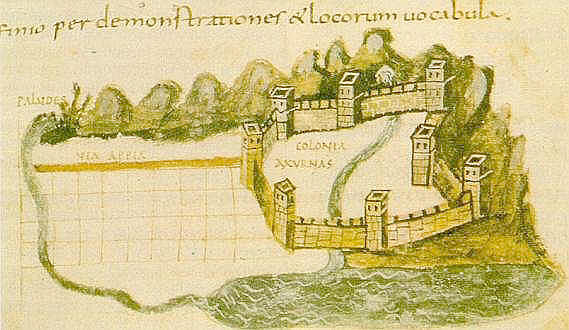
La domus culta di Capracore - Una villa fortificata
del Lazio meridionale. Miniatura dal Corpus agrimensorum del sec. IX -
Roma Biblioteca Apostolica Vaticana - Illustrazione tratta da M. Vegetti, Storia
delle società antiche, Vol 2, Zanichelli, 1981
All’interno della domus cultae
si producevano cereali, vini e ortaggi che erano inviati a Roma ed erano
destinati al sostentamento delle opere di carità: con questi prodotti si
nutrivano circa 100 persone al giorno.
Tali strutture furono raccordate tra loro e con
la città attraverso una rete stradale efficiente, che
consentiva il trasporto delle derrate a Roma in tempi assai rapidi. Con il tempo assunsero un
significato politico e amministrativo, oltre che economico:in ognuna vennero
costruite chiese, oratori e vi si insediarono piccole comunità di membri del
clero che, oltre ad occuparsi della produzione, costituivano dei punti di
riferimento per l’amministrazione, svolgendo una funzione di controllo nei
confronti delle famiglie nobiliari e delle grandi abbazie, che erano gli altri
proprietari terrieri dell’epoca.